
C’è voluto molto tempo, dodici anni direi, perché cominciassi a scrivere in francese. Prima ho tentato di capire come suonavano in francese le mie poesie ungheresi. Poi ho iniziato ad assemblare frasi, testi brevissimi, ma è accaduto tutto molto lentamente. Ho iniziato con i testi teatrali, perché è molto più semplice, basta indicare il nome di chi parla. Il mio non era un francese letterario, buttavo giù conversazioni in una lingua quotidiana, popolare.

Continente K. di Eric Bergkraut (estratto video – link)
Come sarebbe stata la mia vita se non avessi lasciato il mio paese? Più dura, più povera, penso, ma anche meno solitaria, meno lacerata, forse felice. La cosa certa è che avrei scritto, in qualsiasi posto, in qualsiasi lingua.

Nell’Analfabeta, Ágota Kristóf racconta le tappe del suo faticoso e lentissimo processo di appropriazione della lingua francese. Il perno della storia è in quella notte di fine novembre del 1956, quando abbandona da profuga l’Ungheria invasa dalle truppe sovietiche. Non si lascia alle spalle solo tutti gli affetti e tutte le memorie del passato, ma anche una lingua madre che, negli anni durissimi e miserabili del collegio, le aveva offerto la risorsa preziosa dello scrivere poesie.
È il caso a portare la famiglia della scrittrice a vivere vicino Neuchâtel, obbligandola a sfidare quotidianamente la difficoltà di quel francese che diventerà il suo perfetto strumento artistico ma che, durante i primi anni, non riesce nemmeno a leggere.
Emanuele Trevi
Gli anni dell’infanzia compaiono come i più sereni, più che mai presenti negli odori, nei sapori, nei colori, così che l’aula del padre, maestro elementare, sa di gesso, di inchiostro e di carta, ma anche di quiete e di silenzio e per richiamo di neve, e la cucina della madre sa di bestia macellata, carne bollita, latte, marmellata, pipì dell’ultimo nato, e insieme di rumori e di calore estivo anche d’inverno.
E sono altresì presenti, quegli anni, nella lingua, l’ungherese, la lingua materna.
All’inizio, non c’era che una sola lingua. Gli oggetti, le cose, i sentimenti, i colori, i sogni, le lettere, i libri, i giornali erano quella lingua.
Racconto autobiografico che offre un altro punto di vista sull’esilio.
In tal caso sin dal sottotitolo è dichiarata la sovrapposizione tra vicenda narrata ed esperienza di vita dell’autrice: il lettore è autorizzato dalla scrittrice a leggere questa storia come una autobiografia a tutti gli effetti.
Ho lasciato in Ungheria il mio diario dalla scrittura segreta, e anche le mie prime poesie. Ho lasciato là i miei fratelli, i miei genitori, senza avvisarli, senza dir loro addio, o arrivederci. Ma soprattutto, quel giorno, quel giorno di fine novembre 1956, ho perso definitivamente la mia appartenenza a un popolo.
Esilio, in questo caso, è non solo lasciare forzatamente la propria terra ma anche seppellire la propria lingua.
Parlo il francese da più di trent’anni, lo scrivo da vent’anni, ma ancora non lo conosco. Non riesco a parlarlo senza errori, e non so scriverlo che con l’aiuto di un dizionario da consultare di frequente. È per questa ragione che definisco anche la lingua francese una lingua nemica. Ma ce n’è un’altra, di ragione, ed è la più grave: questa lingua sta uccidendo la mia lingua materna.

La storia di Ieri è autobiografica, ma c’è molta fantasia naturalmente. E i ruoli sono capovolti: io sono Tobias, non Line. E, sì, come lui penso che per diventare scrittore bisogna solamente scrivere. Leggere e scrivere molto. E poi buttare via molto.
Ieri è l’ultima opera di Ágota Kristóf, pubblicata nel 1995, quattro anni dopo l’ultimo volume della trilogia.
Una storia d’amore dura come un sasso. Bisogna avere una grande saggezza per raccontare una storia così, senza fronzoli e trucchi. Bisogna essersi lasciati alle spalle le bugie della letteratura e scegliere le parole nella loro povera sincerità. Diventando assolutamente niente che si può diventare scrittori, dice Tobias, l’operaio-scrittore del romanzo.
Ieri è una lezione di stile, un grido assoluto che ci solleva fin dove l’aria è trasparente e tutto si vede chiaramente.
Marco Lodoli

Volevo raccontare di come io e mio fratello Jenő avevamo vissuto la guerra a Kőszeg. All’inizio i narratori eravamo io e mio fratello, ma le parole io e lui in francesce suonano talmente goffe. Così ho unito i pronomi e il narratore è diventato un noi – nous – e non c’era più bisogno di dichiarare chi stesse parlando. Ecco come è nata la voce di questo libro (Il grande quaderno).
Non si tratta di un romanzo completamente autobiografico, ma contiene molti episodi veri. Ad esempio la deportazione degli ebrei da Kőszeg. Io l’ho vista. C’era un campo a Kőszeg, abbiamo visto gli ebrei che marciavano in fila davanti alle nostre case. La nostra domestica si è avvicinata per porgergli del pane, ma poi l’ha riportato indietro.
Una prosa di perfetta, innaturale secchezza, una prosa che ha l’andatura di una marionetta omicida
Giorgio Manganelli
Scriveremo: ‘Noi mangiamo molte noci’, e non ‘Amiamo le noci’, perché il verbo amare non è un verbo sicuro, manca di precisione e di obiettività. ‘Amare le noci’ e ‘amare nostra Madre’, non può voler dire la stessa cosa. La prima cosa designa un gusto gradevole in bocca, e la seconda un sentimento. Le parole che definiscono i sentimenti sono molto vaghe; è meglio evitare il loro impiego e attenersi alla descrizione degli oggetti, degli esseri umani e di sé stessi, vale a dire alla descrizione fedele dei fatti.
Trilogia della città di K.
Nelle sue tre parti il romanzo sfida la logica del lettore, gioca col senso apparente della storia, accenna senza rivelare tempi e luoghi della Storia, racconta orrori e dolori della guerra, dell’occupazione, della miseria. È un romanzo scioccante, estremo, capace di parlare del dolore e della ferocia con spietata essenzialità.
Qual è il percorso dell’autrice di questo libro, cosa l’ha portata a narrare fatti così diversi sfidando il lettore – un lettore abituato a volere che i conti tornino e forse, troppo spesso, con una certa facilità – con una lettura impervia? Ad Ágota Kristóf che i conti tornino al lettore, che la narrazione sia logica e agile probabilmente non interessa perché, probabilmente, quel che le preme è raccontare la sua storia rifratta in una quantità di ricostruzioni diverse.
Ogni personaggio nella Trilogia della città di K., come ogni personaggio degli altri libri di Ágota Kristóf rispecchia la realtà del rifugiato che deve lasciare la propria città, il proprio paese, la propria identità, la propria lingua e gli affetti per cercare salvezza. Questo è quello che ha fatto Ágota Kristóf a ventun anni: ha attraversato a piedi i confini dall’Ungheria alla Svizzera e ha richiesto lo status di Rifugiato. Lei, come i suoi protagonisti, come milioni di persone, ha messo in tasca i frammenti del passato per creare una nuova identità.
Anna Toscano
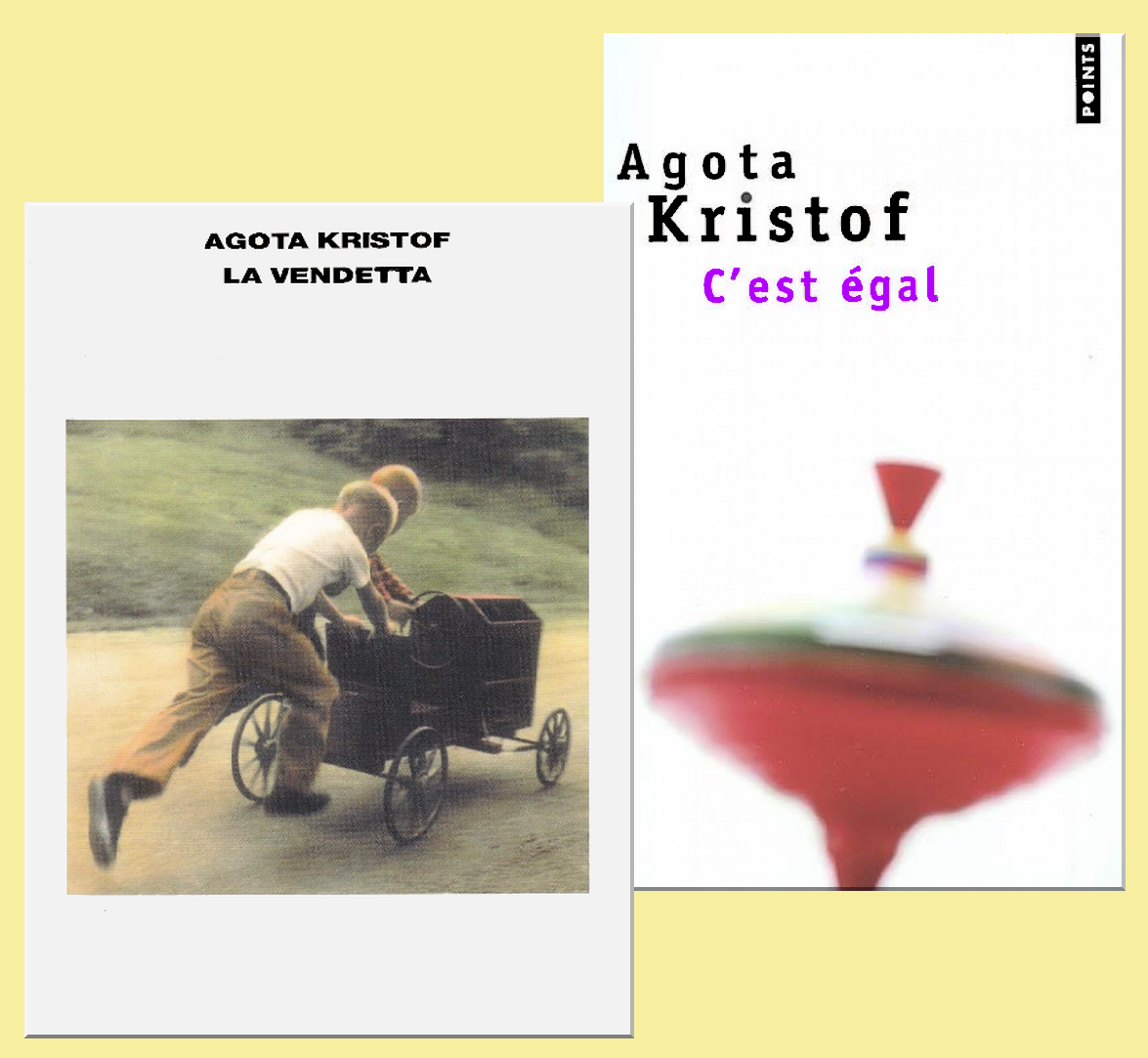
… più ancora dei capolavori come la Trilogia e Ieri, la migliore introduzione al mondo fantastico e insieme al modus operandi della Kristóf è rappresentata dai testi teatrali e dai racconti brevi come quelli raccolti in La vendetta.
Emanuele Trevi
La prima volta che ho letto Je ne mange plus (titolo originale della raccolta di racconti, diventato successivamente C’est égal e in italiano La vendetta) ho avuto l’impressione sconcertante che quei testi mi respingessero, che non volessero “farmi entrare”. Ho messo da parte il dattiloscritto e ho pensato che tradurlo non sarebbe stato uno scherzo.
Un mese più tardi l’ho ripreso … Stavolta non ho riflettuto più di tanto. Ho cominciato dalla prima frase del primo racconto: Entri, dottore. E il testo mi ha preso per mano.
Ci sono autori che vanno tradotti così, credo. Autori che hanno un talento straordinario, nella cui scrittura, per quanto allucinata, per quanto a tratti ermetica – e talvolta queste pagine allucinate ed ermetiche lo sono – non c’è una parola fuori posto, sia a livello dell’architettura della frase, sia a livello puramente lessicale. Di fronte ad autori di questo genere, più che ad altri, la scommessa è riuscire a intonarsi a loro, a intonarne il testo.
Il rigore di Ágota Kristóf , infatti, va ben oltre l’esigenza estetica. È un rigore che nasce dalla tormentata e appassionata relazione della scrittrice con il francese – sua lingua d’adozione che, come lei stessa afferma, non ha ancora finito di imparare. Un rigore che è consapevolezza dei propri limiti e al tempo stesso rivendicazione di una sensibilità linguistica molto peculiare. Un rigore che, coniugato al talento, permette all’autrice di mantenersi in equilibrio tra una lingua impeccabile e sottilissime distorsioni della stessa, scarti minimi, espressioni idiomatiche lievemente forzate, giri di frase inconsulti eppure armonici, puntuali incoerenze nell’uso dei tempi verbali. Sto parlando di un equilibrio che non sempre è possibile rendere appieno; principalmente per due ragioni molto semplici, direi costituzionali: da un lato, io non ho e non posso avere, rispetto all’italiano, la distanza che Ágota Kristóf ha rispetto al francese; inoltre, il francese di Ágota Kristóf è sicuramente attraversato dalla memoria, segnato dall’impronta di un’altra lingua, l’ungherese, che con esso ha istaurato un rapporto segreto, forse difficilmente percepibile anche per l’autrice stessa. L’unica via, quindi, è stata ascoltare il monito: resisti alla tentazione di correggere … ho cercato di lasciarmi portare dal testo, pancia a pancia con esso … confidando in qualche proprietà osmotica del talento.
Maurizia Balmelli

I Chiodi poetici della Kristóf aprono più di una prospettiva, che sembra permetterci di entrare più profondamente nell’universo biografico e immaginario di una scrittrice altrimenti ben poco incline alle confessioni e al racconto di sé, che ha sempre preferito, proiettare la propria individuale e dolorosa esperienza nei suoi personaggi e nelle sue menzogne, come suggeriva di considerare i tre romanzi della trilogia. Ebbene, le poesie di Chiodi, leggendole, abbiamo la sensazione di avvicinarci considerevolmente alla cosa per la quale non c’è parola, e questo avviene per una ragione molto semplice: a farsi garante della voce che parla in questi versi è un io, che imprime alle parole, anche senza volerlo, un’intonazione profondamente affettiva, profondamente sofferta e non di rado tendenzialmente lirica.
La seconda prospettiva aperta da queste poesie è invece di natura linguistica, e di nuovo contribuisce a rendere omaggio alla straordinaria vicenda di una scrittrice che ha dovuto attraversare le lingue.
Poesie tra le lingue, si potrebbe dire, e persino tra le culture. Le vie della creazione letteraria, qui come nella Trilogia, sono state per Ágota Kristóf misteriose e originali, e forse hanno saputo, quasi miracolosamente, trasformare l’esperienza dell’esilio e dello sradicamento in territorio stesso della scrittura.
Le mie mani / rimettono a posto gli occhiali / affinché io scriva: l’ultima poesia di Chiodi, intitolata Non morire, si conclude così, riaffermando con semplice fermezza il motivo della scrittura, che attraversa l’intera opera in versi e in prosa dell’autrice e che costituisce il destino da lei accettato e caparbiamente perseguito.
Fabio Pusterla