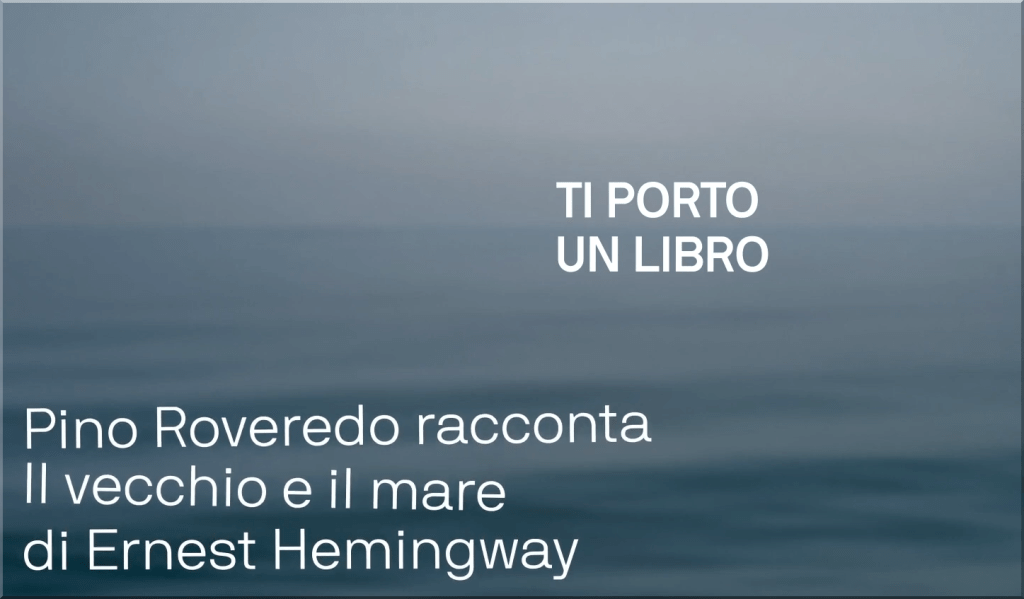Per me, come per tanti che scivolano nel silenzio della solitudine, la scrittura è l’ultima voce, la voce intima che può trovare il coraggio di scrivere nella disperazione, a volte fino a toccare ed a rovesciare il fondo della coscienza, e trasformare, in un impulso, quasi in un’energia fisica, che trova la scorciatoia per uscire dal male.
La scrittura dà la libertà di vincere la paura della memoria e convincersi che nessuno è irrecuperabile.
Dall’esperienza, umanissima e insieme aliena, del manicomio, è nato il più bel racconto di Pino Roveredo, Mandami a dire, in cui solitudine, amore, assurdità, caparbio senso della vita, mistero dell’incontrarsi e del perdersi si fondono in un’opera magistrale, in un vero capolavoro.
Di questo mondo di dolore Roveredo si occupa non solo nella libertà della scrittura, ma anche in un quotidiano impegno di aiuto concreto alle sue vittime. La sua esperienza ha insegnato che bisogna pagare i debiti – verso gli altri, la società, la legge – e aiutare gli altri a pagare i loro e a risollevarsi.
Da anni si è messo al servizio di chi, per sua colpa o disgrazia, vive nell’emarginazione e nel buio, lavorando in varie realtà di disagio e impegnando in quest’opera non solo se stesso ma anche, sia pur con altra funzione, la sua scrittura: ha messo in scena spettacoli con tossicodipendenti e malati di Aids, chiamandoli a collaborare alla stesura dei testi, ha lavorato con i detenuti del carcere di Trieste e con gli assistiti dei centri d’igiene mentale, coinvolgendo la letteratura in quest’opera di riscatto.
Claudio Magris

Sono cresciuto con una sola lingua, la LIS, la lingua dei segni.
Ho imparato la lingua dei segni dai miei genitori, esattamente come un bambino che nasce in una famiglia di udenti impara l’italiano come prima lingua.
Il mio primo segno è stato fame, o almeno così mi hanno detto i miei genitori.
A casa regnava il silenzio, questa è la cosa straordinaria.
Nel mondo del silenzio per comunicare bisogna avere l’educazione della presenza e la cortesia dell’attenzione. I sordomuti parlano con le mani e ascoltano con gli occhi.
Io sono infinitamente grato ai miei genitori per avermi insegnato prima il silenzio che il rumore, ma soprattutto per avermi insegnato delle norme di comportamento che per i sordi sono obbligatorie: ad esempio la lingua dei segni prevede che le persone si guardino negli occhi, e la comunicazione non deve essere mai interrotta.
Sono forme di educazione che mi sono servite molto nella vita, anche nella mia professione di scrittore.

I personaggi di Roveredo vivono spesso ai margini della vita o nell’ombra; egli ne racconta con partecipe affetto e rispetto le violenze anche brutali e le umiliazioni subite, gli sbandamenti o le canagliate ma anche il generoso e spavaldo coraggio, le piroette ed i capitomboli con cui essi cercano di sfuggire alla morsa della vita, i sogni ingenui ma potenti che li portano aldilà dei confini del reale.
Questa familiarità con la debolezza e insieme con la sacralità dell’esistenza è irriverente, perché non arretra dinanzi ad alcuna anche impudica o imbarazzante miseria e non s’inchina ad alcuna solennità, ma la tira giù dal piedistallo, dando del tu o anche peggio al Padreterno e mostrando i rattoppi nei calzoni o i buchi nelle calze della vita.
Come ha scritto in un eccellente saggio Riccardo Cepach, Roveredo non ha nulla da spartire con la grande tradizione trasgressiva di Kerouac e di Bukowski e con la loro visione eroico–contestataria dell’ebbrezza alcolica o del disordine liberatorio: “l’inferno dell’alcolismo viene descritto nella brutalità dei suoi devastanti effetti … Roveredo ha restituito, al di là di ogni facile mitologia, l’alcolismo a chi ne è veramente vittima”.
Claudio Magris

Il mio Campiello – Pino Roveredo racconta (video – link)

Ma non ho scritto solo lettere, sfruttando quella piccola capacità che il sottoscala della condizione mi aveva sempre riconosciuto, ho provato a raccontarmi con l’intimità autobiografica di un manoscritto, manoscritto che è diventato libro, libro che è diventato il salto di un piccolo orgoglio, e che oggi, a distanza di più di vent’anni, è diventato libro di testo in più di cento scuole in Italia.
Il libro è Capriole in salita.
Oggi se qualcuno mi dice che la vita
si vive una volta sola, io posso rispondergli che no,
che la vita, se ti aiutano a credere, la puoi far girare
anche due volte. Sì, anche due volte.
Da lì, da quasi casualità, sono diventato scrittore, anche se io continuo a ribadire di essere solo un autista di parole, e cioè uno che incontra le storie e poi le trasporta su carta, perché convinto che anche con le scritture rasoterra si possono raccontare storie importanti.
Storie che ho conosciuto e conosco bene e che girano nelle estremità, storie che solitamente si guardano senza vedere, si ascoltano senza sentire.
Pino Roveredo
Quello di Roveredo è un “caso” letterario che, almeno all’altezza dell’uscita del suo primo libro, Capriole in salita, ha messo a rumore, a vari livelli, la società culturale triestina. Ed è un caso che ha rischiato di diventare nazionale nel momento in cui Claudio Magris sulle pagine del «Corriere della sera» ha messo al primo posto il libro dell’esordiente triestino nella sezione dedicata alla narrativa italiana della sua personale classifica delle migliori opere apparse nel 1996.
Ecco, il “caso” comincia qui, con una serie di domande che non si possono eludere: che cos’è uno scrittore? Perché scrive? Che cosa lo spinge? E ancora: scrittore è chi sa scrivere? O chi ha qualcosa da dire? O chi vuole dire qualcosa, indipendentemente dal fatto che sappia come farlo?
Le incursioni di Roveredo negli ambienti scomodi e poco noti della estrema povertà, del carcere e del manicomio è quello di chi strappa il velo del conformismo e dell’ipocrisia dagli occhi della società borghese, di chi attacca il pregiudizio e ogni facile giustizialismo, di chi espone la sofferenza per scuotere le coscienze.
Tutto ciò ha contribuito a diffondere la sensazione che Roveredo sia innanzitutto uno scrittore “contro”, un ribelle, un anticonformista, in qualche modo un maudit.
Riccardo Cepach

Il professor Basaglia era arrivato da un po’, e nel Manicomio da qualche mese erano spariti i camici bianchi e gli operai stavano provvedendo all’abbattimento delle reti di protezione dai balconi. I ricoverati giravano nei cameroni senza sorveglianza con le bocche aperte di chi non si rende conto della rivoluzione in atto.
Ed è proprio in uno di quei cameroni che una mattina entrò un giovane dottore che, dopo aver guardato un po’ in giro, urlò: “Io vado in città con la macchina! Qualcuno vuole venire con me?”. Berto fu il primo ad alzare la mano e a vincere la corsa.
La prima volta, la prima volta dopo tanti anni, ma così tanti da non averli mai contati. La prima volta seduto vicino al guidatore con il viso attaccato sul vetro come a volersi tuffare dentro gli spazi che lui amava tanto.
Quella mattina Berto scoprì che esistevano i bambini, sbavò d’incanto davanti ai semafori con i colori confusi. Rise fino al pianto per i cani che pisciavano negli angoli, si stupì per le accelerate fumose che uscivano dagli scarichi, si divertì a imitare i clacson delle automobili nervose, e si emozionò come per un esordio quando vide il mare e le barche che aveva disegnato un milione di volte muovercisi sopra.
Per due ore Berto agitò le mani per salutare la gente, quella gente che per due ore non rispose al saluto e guardò inorridita uno dei primi pazzi in libertà.
Ballando con Cecilia
Pino Roveredo, Pippo Delbono – Che cosa è santo (video – link)
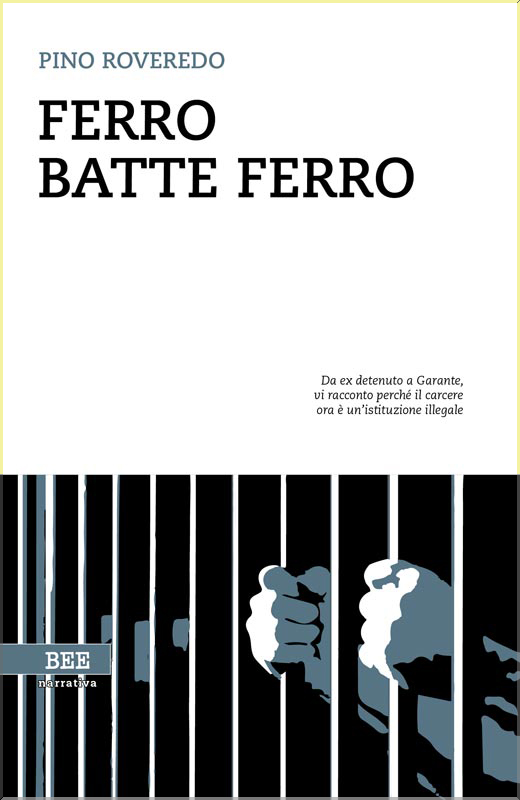
Il carcere è un marchio che non puoi cancellare dalla pelle e dalla vita.
Non importa qual è la referenza della pena: vent’anni, venti mesi, venti giorni, bastano anche venti ore e di diritto la detenzione s’impadronisce della tua sorte.
Il carcere spesso è come una malattia.
Il carcere, il carcere… Scatola vergognosa dove nascondere i disgraziati. Disgraziato io, disgraziato tu, disgraziati tutti quelli che si fanno sporcare le dita con le impronte digitali.
Io, in carcere, ci sono ritornato! Sì, ci sono finito altre tre volte, senza l’eco del grande reato.
Sono diventato uno scrittore, un distinguo che a volte mi è sembrato una esagerazione e che spesso ho accompagnato con la difesa del finché non se ne accorgono vado avanti fino a toccare l’immaginabile: il riconoscimento del Premio Campiello.
Ricordo che quando vinsi, nella ressa della festa fui avvicinato da una giornalista per il rito dell’intervista.
«Ci dica, Roveredo, come si sente?».
«Come mi sento? Guardi, mi sento felicemente penultimo!».
Ferro batte ferro e sbarra chiama sbarra…
Oggi lo posso dire, il ferro si può vincere e le sbarre si possono piegare, e oltre si può trovare il regalo della vita. Mi ricordo che da ragazzino, nei miei primi giri in tribunale, un’assistente sociale ipotizzò per me il ruolo futuro di persona irrecuperabile. Sono quarant’anni che, con tutti i muscoli che posso, riesco a smentirla ogni giorno, un giorno.
Ferro batte ferro

“Ci si limita a guardare il contorno della persona… forse perché guardare con altri occhi, guardare l’altro con profondità… con gli occhi della nostra intimità fa paura, fa male, è troppo faticoso… forse perché è la nostra stessa intimità a farci paura…
Alle volte non abbiamo una buona considerazione di noi stessi… e facciamo cose per compiacere gli altri, per paura dei giudizi altrui e per la solitudine che ci circonda…
Dovremmo cambiare occhi verso noi stessi per comprendere l’altro.
Il paesaggio umano si modifica, anche se spesso sembra resti uguale.
Ma sono proprio quelle piccole sfumature insignificanti e quasi impercettibili ai nostri occhi… che fanno i veri cambiamenti… Il noi e gli altri non sono più percepiti come distinti, ma comprensivi l’uno dell’altro”.
«Parole pre-confezionate/confezionate» Progetto teatrale redatto con i ragazzi del quartiere Rozzol Melara (Trieste, 2009)
Quartiere Rozzol Melara